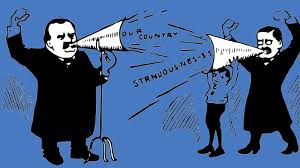 Pubblicato sul manifesto il 16 maggio 2023 –
Pubblicato sul manifesto il 16 maggio 2023 –
Periodicamente ci si interroga sul ruolo degli “intellettuali”, e in particolare sul loro rapporto con la politica.
Si potrebbe cominciare quanto meno dal celebre J’accuse.. di Émile Zola che aprì il caso Dreyfus, e dal pluricitato libro di Julien Benda, Il tradimento dei chierici. Siamo al passaggio tra il XIX e il XX secolo (con già, nel 1927, anno in cui esce il testo di Benda, le avvisaglie di catastrofi ancora peggiori di quella vissuta con la Grande Guerra).
Lo fa in effetti sul sito del Mulino Raffele Romanelli a proposito del recente libro di Giorgio Caravale Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni (Laterza, 2023). Un testo che merita certo recensioni più impegnate di quanto possa e sappia fare in questo breve spazio (ne scrivono anche Piero Craveri e Mario Ricciardi sull’ultimo numero – 14 maggio – della Domenica del Sole 24 Ore).
Mi limito a indicare il tema, che Caravale sviluppa partendo dalla “crisi del modello gramsciano”, con gli intellettuali “organici” vicini o interni al vecchio Pci, e giungendo alle espressioni ingiuriose del populismo di Grillo (anche se i grillini candidarono un intellettuale come Stefano Rodotà alla presidenza della Repubblica) e al disprezzo di Matteo Renzi per i “professoroni” di diritto costituzionale che non apprezzavano la sua riforma della Carta, poi sconfitta nel referendum. (Lasciamo perdere per un momento, ma il tema è cruciale, l’interrogativo di quali siano i riferimenti culturali delle e dei Meloni, Lollobrigida, Salvini ecc.)
E salto subito alle conclusioni, ricordando che in premessa l’autore, partendo da una crisi attuale della politica che è anche crisi culturale, avverte che «…non si tratta…di rimettere insieme i pezzi di un modellino andato in frantumi, quale che fosse, bensì di comprendere appieno ciò che è accaduto nell’ultimo trentennio, di mettere a fuoco ciò che appare oggi, al mio sguardo retrospettivo, come un punto di non ritorno, un momento di radicale svolta, in una storia più che centenaria».
Le conclusioni, direi, si sforzano di essere ottimistiche: superata l’epoca degli stretti (troppo stretti) affidamenti reciproci tra politica e cultura, e si spera anche quella del disprezzo reciproco, Caravale si sforza di vedere nell’ «abissale distanza che separa oggi il mondo della cultura da quello della politica» anche «un’inedita opportunità». E cioè una realtà fatta di studiosi che ritrovino il gusto di riflettere sull’agenda politica da posizioni di autonomia, con possibilità di dialogo e scambio con una politica che, dopo aver abbandonato pretese “egemoniche”, dismetta anche i più recenti pregiudizi anti-intellettuali. Augurandosi infine che «il mondo universitario ritrovi le condizioni per liberarsi dalla soffocante logica corporativa accademica».
Quante cose, tutte insieme! Riconosce lo stesso autore… E in effetti, per quel non molto che ne so, aspettarsi anche solo l’ultimo dei mutamenti positivi auspicati, nel modo di essere dell’Università, assomiglia un po’ a una azzardata utopia.
Aggiungo che nella ricca ricostruzione di questi ultimi trent’anni italiani temo manchi la domanda di fondo: per quanto criticabile fosse, perché è saltato quel rapporto forte tra cultura e politica? Azzardo che si tratti di un effetto della sconfitta epocale della ipotesi di trasformazione (socialismo versus capitalismo) che ha dominato le dialettiche della politica e della cultura per circa due secoli.
Un trauma così radicale che ancora impedisce a molti di riconoscere quali diverse ipotesi di cambiamento – e di ricerca – oggi possano essere in campo.
 Follow
Follow